storia del m.s.i. e biografia di giorgio almirante
| MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - ALLEANZA NAZIONALE: 60 anni di storia che non si cancellano |  |
 |
 |
| Scritto da Michele Leoni | |
| Wednesday 18 March 2009 | |
|
|
| Giorgio Almirante, biografia |  |
 |
 |
| giovedì 22 maggio 2008 | |
Uomo politico, nato a Salsomaggiore, in provincia di Parma, il 27 giugno 1914 e morto a Roma il 22 maggio 1988 Giorgio Almirante nasce in una famiglia di artisti appartenenti all’alta nobiltà di Napoli. Duchi di Cerza Piccola dal 1691, la famiglia Almirante si sposta continuamente da una città all’altra per seguire il padre, attore e direttore di scena della compagnia di Eleonora Duse e Ruggero Ruggeri. Dopo dieci anni in giro per l’Italia, la famiglia si stabilisce a Torino dove il piccolo Giorgio Almirante intraprende i suoi primi studi. Consegue il diploma presso il Liceo Classico Vincenzo Gioberti e successivamente si iscrive alla Facoltà di Lettere dell’Università di Roma, città nella quale si era trasferito con la famiglia, laureandosi nel 1937 con una tesi sulla fortuna di Dante nel Settecento italiano con l'italianista Vittorio Rossi. In quello stesso periodo comincia a collaborare come cronista praticante presso Il Tevere, un quotidiano fascista diretto da Telesio Interlandi che era stato fondato su invito dello stesso Benito Mussolini per dare voce alla componente più spregiudicata e aggressiva del fascismo in appendice al Popolo d’Italia, organo di stampa ufficiale del regime. Giorgio Almirante nasce in una famiglia di artisti appartenenti all’alta nobiltà di Napoli. Duchi di Cerza Piccola dal 1691, la famiglia Almirante si sposta continuamente da una città all’altra per seguire il padre, attore e direttore di scena della compagnia di Eleonora Duse e Ruggero Ruggeri. Dopo dieci anni in giro per l’Italia, la famiglia si stabilisce a Torino dove il piccolo Giorgio Almirante intraprende i suoi primi studi. Consegue il diploma presso il Liceo Classico Vincenzo Gioberti e successivamente si iscrive alla Facoltà di Lettere dell’Università di Roma, città nella quale si era trasferito con la famiglia, laureandosi nel 1937 con una tesi sulla fortuna di Dante nel Settecento italiano con l'italianista Vittorio Rossi. In quello stesso periodo comincia a collaborare come cronista praticante presso Il Tevere, un quotidiano fascista diretto da Telesio Interlandi che era stato fondato su invito dello stesso Benito Mussolini per dare voce alla componente più spregiudicata e aggressiva del fascismo in appendice al Popolo d’Italia, organo di stampa ufficiale del regime.
Alla "terza pagina" del Il Tevere collaborano, oltre ad Almirante, Luigi Pirandello, Emilio Cecchi, Giuseppe Ungaretti, Vincenzo Cardarelli, Vitaliano Brancati, Antonio Baldini, Corrado Alvaro, Carlo Bernari, Ercole Patti, Ardengo Soffici, Julius Evola, Luigi Chiarini, Umberto Barbaro. Durante la sua permanenza al giornale, Almirante viene promosso redattore capo e, nel 1938, è anche segretario di redazione della rivista “La difesa della razza”, esperienza, quest’ultima che sconfessò completamente pur ammettendo di essere stato, per motivi politici, razzista e antisemita, firmando nel 1938 il Manifesto della razza. |
|
| Ultimo aggiornamento ( giovedì 18 giugno 2009 ) |
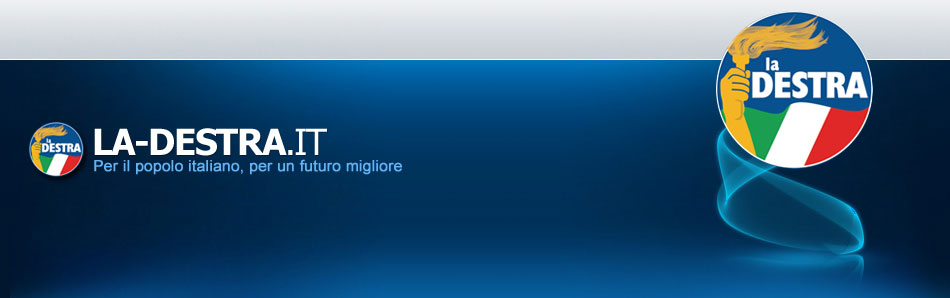
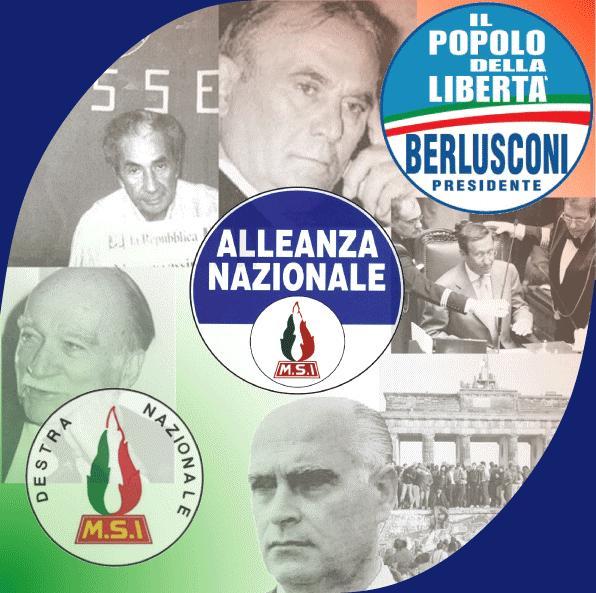 Il prossimo fine settimana traslocherà un grande pezzo di storia della politica italiana, la Destra si scioglierà e confluirà nel grande partito riformista che si chiama il Popolo Delle Libertà.
Il prossimo fine settimana traslocherà un grande pezzo di storia della politica italiana, la Destra si scioglierà e confluirà nel grande partito riformista che si chiama il Popolo Delle Libertà. 








